L'ultima fatica, a 85 anni, è un omaggio al Boccaccio. "Un rivoluzionario", dice il premio Nobel
Che parla di santi e giullari, di esordi e successi, di fascismo e '68. E dell'Italia dei giorni nostri
di ANTONIO GNOLI
Dalle parti di Gubbio, a Santa Cristina, c'è la Libera Università di Alcatraz, un luogo ameno tra le colline Dalle , dove Dario Fo mi riceve. Qui passa alcuni mesi dell'anno, con Franca Rame, il figlio Jacopo (motore e ideologo di questa comunità dedita alla cura del corpo e dello spirito) e una schiera di giovani che fanno il loro apprendistato. Nell'atelier dove aspetto l'arrivo di Fo tre ragazze lavorano alla rifinitura di un quadro. Altre tele sono appoggiate a una parete. C'è chi scrive al computer e chi telefona. L'atmosfera è armoniosa. Non riesco a capire - lo dico senza ironia - se questo luogo sia un reperto del passato o una scommessa per il futuro. Ma in fondo è solo un pensiero.
Il Decameron disegnato da Fo
Sono qui per Fo, per il suo nuovo libro dedicato al Boccaccio, una riscrittura per parole e immagini delle sue novelle. Ma sono qui anche per capire che cosa resta di questo monumento della cultura alternativa, quand'ecco che si materializza. Chiede un bicchiere di latte, si siede comodo, mi guarda premuroso. È imponente senza essere intimidatorio, il sorriso è bello. Ha da poco compiuto ottantacinque anni. Si scusa per avermi fatto attendere, ma con la Franca hanno passato una nottata in bianco e poi una mattina a tentare di risolvere una fastidiosa bronchite. È un uomo innamorato quello che mi sta di fronte. Innamorato di Franca, del teatro, della vita. Dell'umanità. Gli chiedo se si considera fortunato. "Lo sono, lo sono", dice con una certa ritrosia. "In fondo ci sono stati personaggi grandissimi che non hanno avuto in sorte la stessa fortuna".
Come Boccaccio?
"Muore povero e dimenticato. Ma la sua grandezza è cristallina. Rivoluziona la letteratura ed è un gesto che trasforma radicalmente anche il teatro. Ha alle spalle i fabliaux, i racconti in versi medievali".
A proposito di teatro, nel Decameron c'è la grande trovata scenica dei giovani che si ritirano in collina mentre in città, a Firenze, infuria la peste.
"Ma è anche un fatto storico e Boccaccio deve stare attento a raccontare, sapendo cosa rischiano gli scrittori, i giullari. Su tutto pesa l'editto di Federico II di Svevia che impone la gogna e la morte ai buffoni maldicenti".
Boccaccio arriva dopo Dante, in cosa gli è debitore?
"Sono due nature immense, ma mentre potrei forse prescindere da Dante non saprei farlo con Boccaccio. La sua grandezza è aver posto Dio a un lato del suo mondo, mentre Dante continuamente lo colloca al centro. Per questo la condanna della Chiesa è molto più forte nei riguardi di Boccaccio".
Le piacciono le figure rivoluzionarie.
"Mi piacciono le figure che rischiano e che inventano linguaggi".
Però ha una predilezione per i santi.
"In genere quando noi pensiamo ai santi immaginiamo il santino. Ma i santi d'Italia erano spesso trasgressori, rivoluzionari: gente che rischiava la vita, che finiva in galera o sul patibolo".
E perché la Chiesa li beatificava?
"Perché era forte la loro presa popolare, e poi mica tutti venivano fatti santi. Di Jacopone da Todi, considerato un santo dalla popolazione, la Chiesa ha cancellato perfino le spoglie".
La religione è una delle fonti alle quali lei si ispira. È così importante per un laico come lei?
"Distinguerei tra religione e religiosità".
Qual è la differenza?
"La religione è un fatto istituzionale, la religiosità un atteggiamento composto di credenza e ritualità. La religiosità, per esempio, non può prescindere dall'osceno. Pensi al risus paschalis, uno dei riti collettivi liberatori più importanti di tutta la storia della Chiesa. La loro narrazione ha sempre per oggetto cose proibite. Nell'iconografia il vescovo è rappresentato sopra la comunità dei fedeli, mai dentro. Il che indica il distacco tra la Chiesa e il popolo che praticava quei riti".
Che sono in fondo un'eredità pagana.
"Il paganesimo sopravvive nell'esperienza popolare: il grande capro, il serpente tentatore, le creature della terra, il valore stesso della vita collettiva trovano un collante nel riso. Attraverso il riso si buttavano all'aria le consuetudini sbagliate, le forme meschine del potere. Pazzia, ironia, grottesco e perfino la morte fanno parte della religiosità popolare e il teatro è il luogo giusto per esaltarli".
Come è nato il suo innamoramento per il teatro?
"Sono nato a Sangiano, una terra di fabulatori meravigliosi. Da quelle parti c'era una vetreria dove ogni anno si davano appuntamento da tutta Europa i soffiatori di vetro. Arrivavano con le loro famiglie, comunità intere che si spostavano e ciascuna aveva i loro raccontatori. A dieci anni ho capito il valore delle lingue, dei dialetti e delle storie che venivano narrate".
Fu un apprendistato?
"Un'educazione all'insolito e al trasgressivo. Ma io volevo dipingere, perché questa era la mia passione. Frequentai il liceo artistico e poi l'Accademia. Furono otto anni durante i quali tutte le mattine prendevo il treno per Milano e tutte le sere tornavo al mio paese. Sul treno ho avuto la mia formazione di attore: recitavo su richiesta e mi consideravano bravissimo".
Ma la pittura restava il primo amore.
"Non potevo farne a meno. Frequentavo Brera, ma alla fine - anche per una crisi legata a un malessere interiore - il teatro ha avuto la meglio".
Dice che frequentava Brera, anche il bar Giamaica?
"Certo, ma siamo già nel Dopoguerra. Il Giamaica non era solo un luogo di bevute o di corteggiamento delle puttane, lì vicino era tutto un pullulare di casini, ma anche un posto dove si davano appuntamento scrittori, artisti, fotografi, teatranti. Ho imparato più cose lì e nelle osterie e latterie di quella zona che in tutti gli anni della scuola".
Il fascismo era già un ricordo.
"Un incubo dal quale eravamo usciti. Scoprivamo la libertà. Era come avere a disposizione un grande foglio bianco sul quale poter scrivere quello che ci pareva senza per questo finire in galera. E inoltre erano saltate le gerarchie dei generi: potevi mescolare il teatro drammatico con l'avanspettacolo e il risultato, sorprendente, era la nascita di una nuova forma di avanguardia".
La sua consacrazione teatrale si realizza con il Sessantotto.
"Fu naturale che ciò accadesse. I presupposti di questo successo erano tutti nella commedia dell'arte i cui interpreti, tra il Cinque e il Settecento, dominano l'Europa teatrale. Sono i comici ad abbattere alcuni limiti imposti al teatro".
Quali?
"Per esempio il fatto che le donne non potessero recitare. Sono stati i comici italiani a rompere l'interdetto, per cui il massimo che si potesse fare era far recitare la parte a una finta donna, a un travestito".
E questo elemento "rivoluzionario" è la chiave con cui entra nel Sessantotto?
"È la risata trasgressiva e ludica che risveglia il mondo".
Ma non crede di essere stato un'eccezione?
"No, sono stato la conseguenza di un movimento straordinario".
Che però ha poi preso tutt'altra direzione.
"È come se fossi nato nel punto dove si depongono le uova che si schiuderanno. Non posso certo cambiare. Vengo da quell'occasione. Ogni qualvolta accadeva una novità, un'effervescenza, una trasgressione io c'ero. Recitavo Mistero buffo, e sa cosa è stato il mio successo in tutta Europa? Trasgredire, portare un vento di novità, rompere con i canoni fino ad allora dominanti sul mondo della cultura. Da 'buffone' conobbi Jean Paul Sartre e lui impazzì per me, per quello che rappresentavo con il mio teatro".
Eppure questa linea è restata minoritaria nel Sessantotto.
"Ma le cose migliori vengono proprio da quella esperienza. Non si capirebbe Benigni e il suo Dante senza questo sfondo. Il problema è che oggi per i giovani è molto più difficile fare satira. La televisione è in mano a un manipolo di scellerati. Con Giorgio Albertazzi abbiamo realizzato sedici puntate sul teatro, tutte trasmesse dopo l'una di notte. E nonostante ciò facevano più di un milione di spettatori a puntata".
In che Paese ritiene di vivere?
"Stanno cercando in tutti i modi di distruggere la cultura. Ma il vero massacro non è nel tenere in disparte persone come me, che comunque hanno avuto la loro storia, ma condannare i giovani al silenzio, mortificandone la creatività. C'è un premier che è rimasto alle barzellette e non ha capito che il linguaggio del mondo è anni luce avanti. Sta facendo dell'Italia la sua tomba".
Sembra l'accusa accorata di un premio Nobel.
"Lo sono".
Cosa le ha dato e cosa le ha tolto quel premio?
"È stato il coronamento di una vita culturale. Ma guai se mi avesse impedito di andare oltre. Franca mi dice spesso: meno male che non vesti mai i panni del premiato".
Se lo aspettava?
"Ero già stato in lizza dieci anni prima. Poi in alcuni ambienti cominciò a circolare la notizia che avevo vinto il Nobel, per cui l'Accademia mi tolse dalla lista. Lo venni a sapere molto dopo".
Lei ha dichiarato una volta che il Nobel lo avrebbe meritato "quel reazionario" di Borges.
"E lo confermo".
Ma se fosse stato lei a dover scegliere se dare il premio a Borges o a Dario Fo, come si sarebbe comportato?
"Con tutta la gioia, il rispetto, la considerazione avrei detto: lo merita senz'altro Borges. Ma meno male che ci sia stata un'ingiustizia a mio vantaggio!".
Ora vive qui ad Alcatraz?
"Solo una parte dell'anno. Ho una fattoria non lontano da Cesenatico con uno spazio per lavorare ai miei quadri. Del resto anche qui c'è un atelier dove dipingo".
Quando dipinge?
"È un'attività che non ho mai abbandonato. Ma è soprattutto quando vado in crisi, quando non riesco a risolvere un problema che dipingo e disegno rimettendo in moto il cervello".
E a Milano torna?
"Certo, ma non volentieri".
Che impressione le fa?
"Orrenda. Non ha più un'anima. Non c'è slancio, follia, creatività. Eppure resta una città generosa. Ma io che vi sono arrivato da ragazzino non trovo più il piacere di starci".
Fa ancora volentieri teatro?
"Quello che faccio è solo per i giovani. Il teatro si compone di cielo, di terra e di sottosuolo. Il cielo è coperto, la terra è arida e il sottosuolo è sempre più buio".
 -«The man who screwed an entire country» l' uomo che ha fottuto un intero Paese». L'Economist torna ad attaccare Silvio Berlusconi bocciandone senza appello la politica di governo. Il presidente del Consiglio italiano è tornato in copertina del settimanale britannico in uscita venerdì, a otto anni dal celeberrimo «unfit to lead Italy», inadatto a governare l'Italia, e a cinque dall'altrettanto polemico «E' tempo di licenziarlo». L'occasione di quest'ultima «cover story» è la pubblicazione di uno speciale di 16 pagine sull'Italia realizzato per l'anniversario dei 150 anni. L'analisi di John Prideaux, autore del rapporto, lascia emergere un Paese fermo che paga con la «crescita zero» le mancate riforme. «L'Italia ha tutte le cose che le servono per ripartire, quello che serve è un cambio di governo».
-«The man who screwed an entire country» l' uomo che ha fottuto un intero Paese». L'Economist torna ad attaccare Silvio Berlusconi bocciandone senza appello la politica di governo. Il presidente del Consiglio italiano è tornato in copertina del settimanale britannico in uscita venerdì, a otto anni dal celeberrimo «unfit to lead Italy», inadatto a governare l'Italia, e a cinque dall'altrettanto polemico «E' tempo di licenziarlo». L'occasione di quest'ultima «cover story» è la pubblicazione di uno speciale di 16 pagine sull'Italia realizzato per l'anniversario dei 150 anni. L'analisi di John Prideaux, autore del rapporto, lascia emergere un Paese fermo che paga con la «crescita zero» le mancate riforme. «L'Italia ha tutte le cose che le servono per ripartire, quello che serve è un cambio di governo».







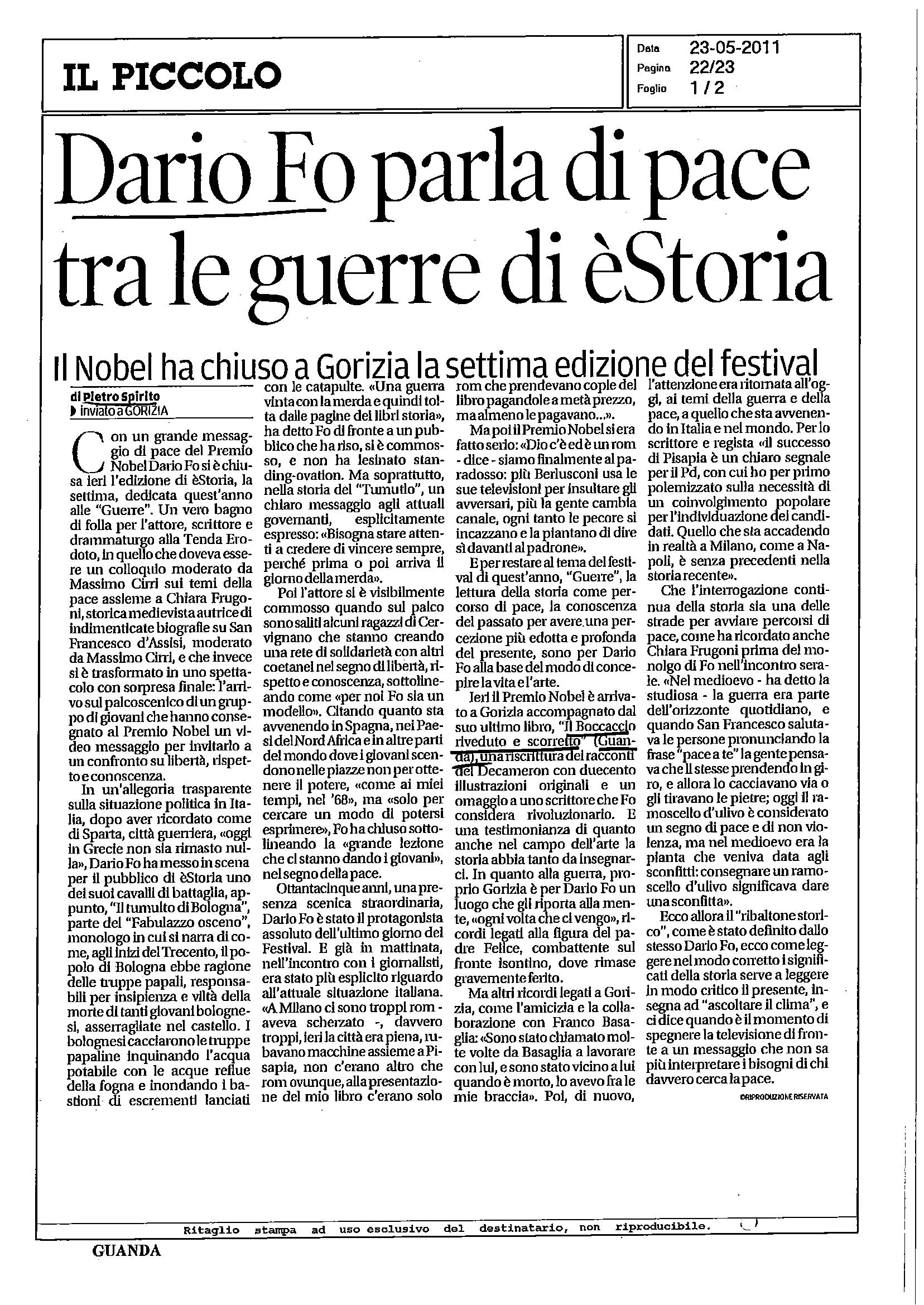
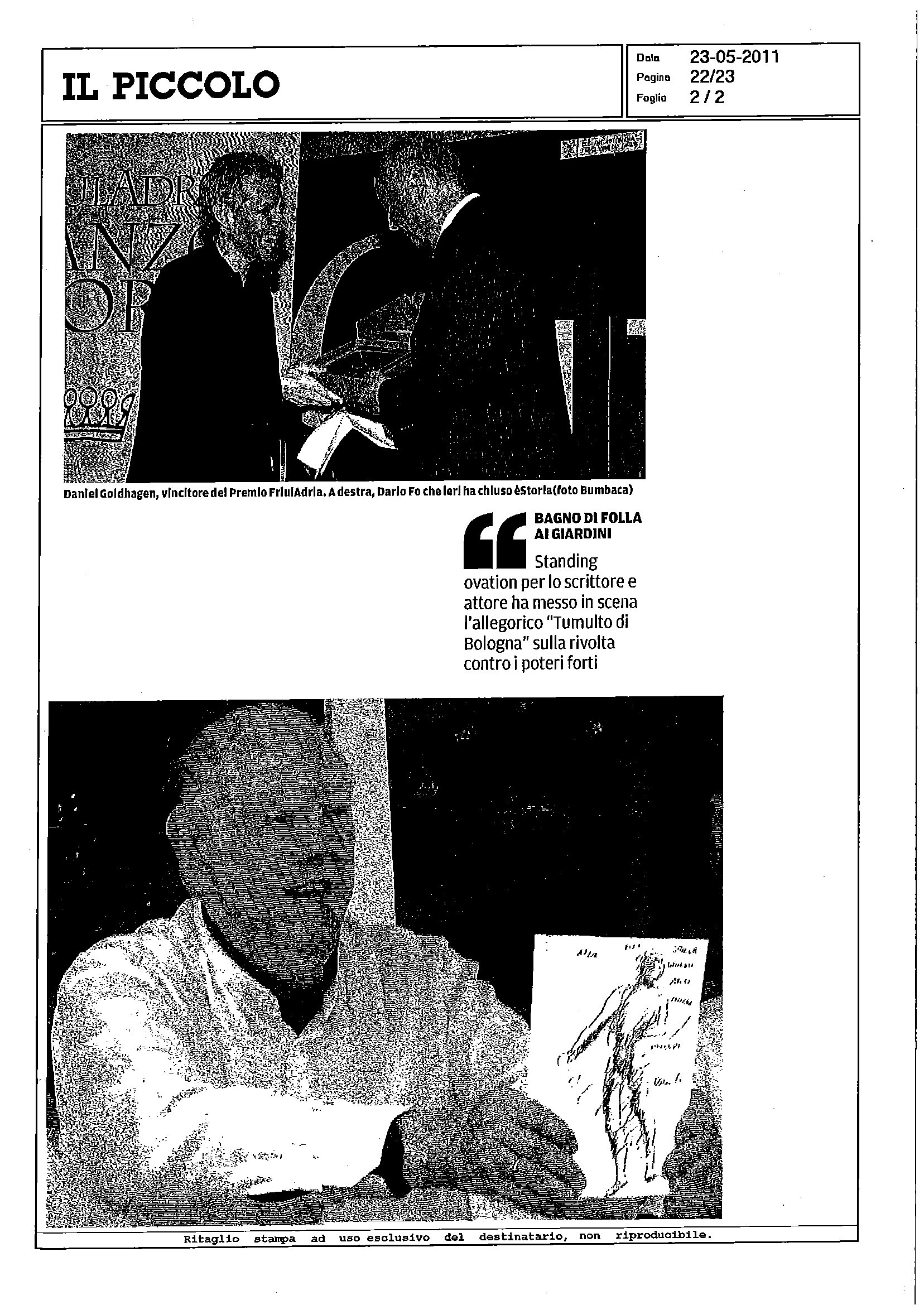

 Sarà un allestimento coinvolgente e ricco di trovate quello che Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura 1997, sta preparando per Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, prossimo appuntamento della Stagione Lirica 2011 del Teatro Massimo Bellini, in programma dal 10 al 19 maggio prossimi.
Sarà un allestimento coinvolgente e ricco di trovate quello che Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura 1997, sta preparando per Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, prossimo appuntamento della Stagione Lirica 2011 del Teatro Massimo Bellini, in programma dal 10 al 19 maggio prossimi.